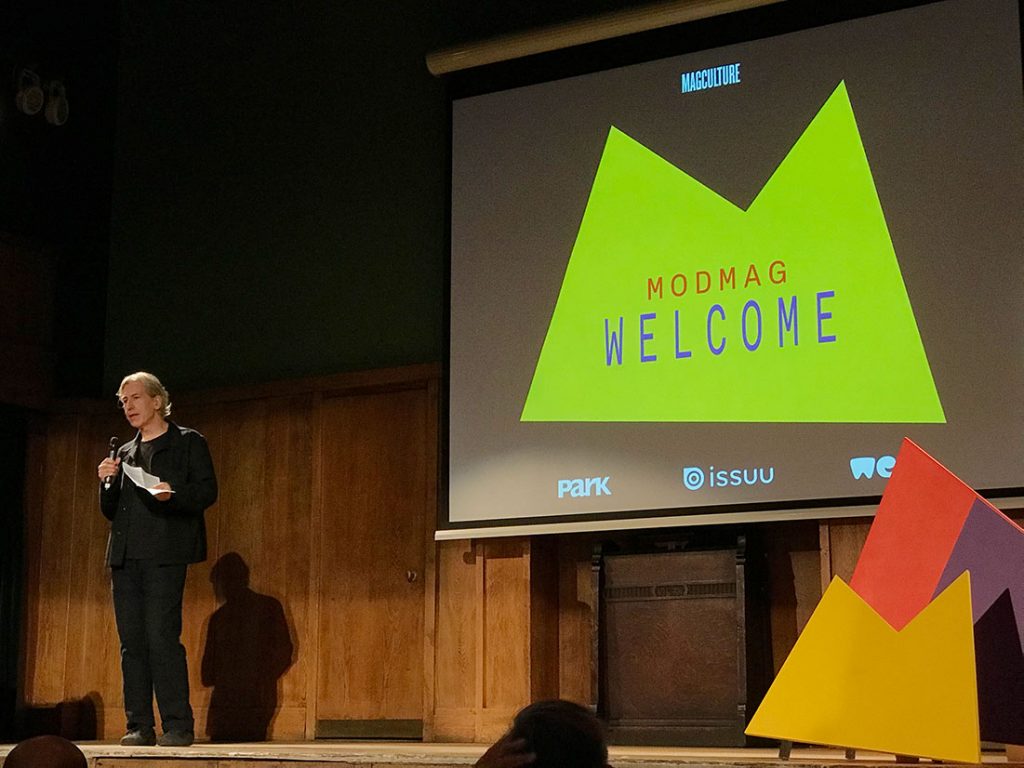L’1 Novembre a Londra si è svolta la sesta edizione di Mod Mag, la conferenza dedicata all’editoria periodica, a cura di MagCulture. Ecco i momenti più interessanti e i personaggi che, intervenuti sul palco, hanno saputo tenere il pubblico incollato alle sedie.
Il tema di questa edizione è “Reinvention”, cioè la capacità di reinventare un prodotto editoriale nel tempo o nella sua offerta diversificata.
Ad aprire gli interventi è Carol Montpart, co-founder e co-art director di “The Plant”. La rivista nasce per affrontare il tema della natura e delle piante da un punto di vista non tecnico ed è stata lanciata quando l’attenzione per questi temi non era forte come adesso, grazie ai social media: racconta una vera e propria esplosione si è vista intorno al numero 8, quando la popolarità del tema aveva ormai raggiunto quelle piattaforme. Pur non essendo un magazine che si interessa di politica, di sicuro si interessa di geopolitica e parte della “reinvention” sta nel pensare a contenuti editoriali innovativi (cita un articolo su un refugee camp) sia nel design, rivisitando le dimensioni e la testata stessa. In fondo, come si trova a ripetere spesso, le piante stesse sono un forte simbolo di continuo rinnovamento, la rivista non può essere certo da meno.
Racconta anche di come una sezione un po’ ibrida della rivista, quella finale, chiamata “Loose Leaves”, sia diventata tra le più popolari: lì si raccolgono tutti quei pezzi che in qualche modo non hanno trovato spazio nel numero o nei numeri precedenti, trattati completamente in bianco e nero.
Regala anche un’anteprima del prossimo numero, il tredicesimo, mostrando le immagini di un articolo sul birdwatching per il quale una costumista ha disegnato abiti e becchi ispirati al mondo degli uccelli, e immagini inedite (“Flowers”) di Linda McCartney, addirittura accompagnate da qualche riga di introduzione del più famoso McCartney della famiglia, il Beatle Paul.
Segue, con ritmo incalzante e accattivante dinamismo, Jeff Taylor di Courier. Parte mettendo subito l’accento su qualcosa che spesso, negli interventi di questa conferenza, viene dimenticato o messo in disparte: il business (del resto, Courier parla di imprenditoria). Ricorda che il design for design’s sake (design fine a se stesso) non serve a nulla e che non è sostenibile una rivista che si basa sull’unica premessa del “faccio ciò che mi piace”: bisogna convincere le persone ad amare ciò che facciamo, bisogna far sì che ciò che facciamo sia qualcosa per cui le persone siano disposte a pagare dei soldi. Sembra una banalità, ma in questo contesto significa invece mettere i piedi per terra e aprire gli occhi alla realtà delle cose.
Mostra in una carrellata tutti i numeri di Courier e la sua evoluzione, che si rivela costante: nelle dimensioni e nel modello di business che da freepress distribuito a Londra per la prima volta nella primavera del 2013 (con tiratura che ha nel tempo raggiunto le 40.000 copie), diventa a pagamento nel numero 19 (ottobre/novembre 2017). Non manca di raccontare episodi divertenti e aneddoti: “al primo numero abbiamo lavorato in tre persone, ma ci vergognavamo a fare un colophon con solo tre nomi, così lo abbiamo riempito di nomi falsi, tra cui amici di infanzia e persone totalmente inventate”, racconta, “e la pagina pubblicitaria in quarta di copertina? In realtà me l’ha passata un amico che lavorava per un’agenzia pubblicitaria”.
Da allora le cose sono cambiate, sono un bimestrale diffuso in 25 nazioni e lo scorso febbraio sono tornati nel mondo freepress con “Courier London”, che intendono lanciare anche in altre città. All’attività editoriale affiancano eventi e conferenze, oltre a una newsletter settimanale (promette che il lato digitale verrà ampliato nel 2019). Nel descrivere in questi termini le attività, non posso non pensare a Courier come ad un Monocle per un pubblico più allargato (un complimento, per quel che mi riguarda).
Suggerisce di pensare ad una rivista come ad un’app: un prodotto che riceve piccoli aggiornamenti, ma costanti. Nel tempo Courier ha cambiato molte volte formato, foliazione, carte e impaginazione, arrivando oggi ad avere cinque sezioni fisse per facilitarne la fruizione da numero a numero. Uno degli obiettivi che Taylor e il magazine si pongono è di creare una rivista che possa essere fruita in 5 minuti così come in 25, a seconda del lettore che si trova davanti: “inutile girarci intorno”, dice, “le nuove generazioni non sono lettori in senso tradizionale, sono abituati ai social media che sono mezzi per la maggior parte privi di testo”. Bisogna, quindi, adeguarsi e progettare per loro, non per un’ideale romantico di lettore che non esiste più.
Jeff Taylor, che dire, mi sei piaciuto un sacco.
Tocca poi a Perrin Drumm, fondatrice di Eye on Design, sito e rivista di AIGA (Professional Association for Design in America), oltre che co-fondatrice della rivista Mold. Anche il suo intervento si rivela molto interessante: innanzitutto Eye on Design è tra le mie letture preferite, so che ogni settimana ci saranno almeno 2-3 articoli che finiranno salvati per sempre nel mio Evernote e che non saranno semplici pezzi riciclati da qualche altro sito o scopiazzati da un comunicato stampa, come la maggior parte dei contenuti che girano online. Perrin – che viene annunciata come una brava speaker (del resto, leggo online che ha fatto da ghost writer per vari TED speaker!) – non delude e mi conquista dicendo che non hanno mai voluto contrapporre digitale e stampa, anzi: il digitale è stato fondamentale per costruire una community di persone interessate al design e ai temi ad esso correlati (etica, sessismo, formazione, salute mentale…), prima di lanciare una rivista cartacea. Su entrambe le piattaforme trattano il contenuto nello stesso modo, facendo attenzione all’esperienza di lettura e cercando di non allontanare il lettore aggiungendo quella che lei chiama design bs (potremmo dire “caxxate grafiche”), pur mantenendo una personalità e una certa percentuale di imprevedibilità anche nel sito web.
Il magazine, quadrimestrale, è un “viaggio che affronta un tema specifico in profondità”, l’invisible nel primo numero (marzo 2018), la psiche nel secondo (agosto 2018). A livello grafico, solo il 5% della rivista rimane costante tra un numero e l’altro (tra cui la cover e un minimo di coerenza di brand), mentre il resto cambia e segue il tema in esame.
Eye on Design è una rivista molto costosa (fa uso di carte preziose e colori speciali, la stampa è molto curata) e Perrin svela che ha cominciato ad essere in attivo due mesi dopo il lancio. Inizialmente finanziata grazie ad un fondo AIGA, a breve si staccherà e diventerà un’unità indipendente, for profit. Da non dimenticare, sempre per comprendere la sostenibilità di un progetto come questo, che si sono avvalsi della collaborazione di partner come Mohawk Paper, Hemlock Printers e Google Design. Infine Perrin Drumm confessa che cominceranno a vendere spazi pubblicitari anche sul sito e sulla newsletter, ma “con gusto”.
Segue un intermezzo con Ian Birch (autore del libro “Uncovered”, oltre che storico editor di Time Out, Smash Hits, Sky Magazine) e Olivia Ahmad (curatrice della House of Illustration a Londra), moderatore Jeremy Leslie, in cui mostrano una veloce carrellata di iconiche copertine di riviste e svelano alcuni retroscena. Sarei stata ad ascoltare Birch per ore, ma il tempo sembra mancare… per fortuna c’è il libro, da avere a tutti i costi.
E’ il momento di Mundial e del suo direttore, Dan Sandison, che, con il suo forte accento di Liverpool, si concentra per lo più sul descrivere l’evoluzione delle copertine del magazine che, lanciato nel 2014 in occasione dei Mondiali in Brasile, ha visto vari cambiamenti e compromessi: da copertine più “poetiche” che presentano solo il ritratto di un grande campione del calcio internazionale, ad altre che fanno uso di strilli e tipografia più evidenti, per catturare maggiormente l’attenzione, notando un incremento nelle vendite e conseguentemente un posizionamento nel mercato. “Non siamo un magazine retro”, spiega, “quindi non possiamo avere in copertina solo i volti delle leggende di questo sport”. Spiega anche come rendere il primo numero collezionabile (attraverso l’inserimento una specie di raccolta di card numerate, a mo’ di raccolta di figurine) abbia trascinato le vendite, ma sia stato estremamente costoso e poco pratico: “non ho ancora finito di pagare quel numero”, dice scherzando. L’intervento è divertente, ma non molto di più.
Sale sul palco Jana Al Obeidyne che arriva da Beirut per parlare di A Dance Mag. La missione della rivista è di cambiare la percezione della danza, per moltissimi legata all’immagine di una ballerina classica. Spiega che per fare ciò sono richieste tre fasi: significa intendere come danza ogni movimento nel mondo, creare una piattaforma (la rivista) che consenta una ridefinizione multiculturale della danza e un nuovo manifesto e, infine, dare voce ai nostri corpi che sono stati “auto-censurati”. Il primo numero di A Dance Mag, finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding su Indiegogo, ha per tema la “trascendenza” e sfogliarlo vi stupirà: le pagine sono per lo più coperte da testo e il compito di illustrarle è stato dato ad immagini astratte che riprendono forme circolari (le stesse forme che il nostro corpo compie naturalmente quando ci muoviamo). L’effetto però è sorprendente, perché la rivista pare muoversi e danzare, anche senza mostrare alcun ballerino sulle sue pagine.
Dopo la pausa pranzo, è il momento di Elisabeth Krohn di Sabat Magazine (e attualmente Suspira), la rivista dedicata alla stregoneria, progettata per essere una trilogia (The Maiden Issue, The Mother Issue, The Crone Issue) e per questo motivo già conclusa ormai un anno e mezzo fa. L’intervento è piuttosto breve e conciso, la Krohn racconta del successo ottenuto in particolare negli USA grazie a Instagram (la piattaforma per eccellenza per la strega contemporanea, a quanto pare) e di come abbia inteso Sabat come una sorta di oggetto magico, un talismano più che una semplice rivista di moda per streghe, grazie a una serie di simboli nascosti (dalla testata, stampata in vernice lucida, alle pagine semitrasparenti usate nel secondo numero, fino alla labbratura di ogni numero che mostra immagini nascoste). Interessante, poi, la scelta del trattamento in bianco e nero di tutte le fotografie, per uniformare dal punto di vista grafico e cromatico i materiali provenienti da diversi collaboratori, contribuendo così alla creazione di una nuova estetica gotica.
Segue Reagan Clarke di Homesick: giovane archivista, la sua rivista ha proprio un approccio da archivio del passato e, dopo due numeri usciti come freepress e stampati su carta di giornale, il terzo sarà a pagamento.
Ben più interessante è l’intervento di Rod Stanley di Good Trouble. Racconta che tutto è nato con un blog aperto l’indomani dell’elezione di Trump alla presidenza americana. Good Trouble è una bella sperimentazione grafica in formato broadsheet che non è però fine a se stessa, bensì vuole essere veicolo di cambiamento sociale e critica al sistema.
Prende il nome da una frase pronunciata dal deputato John Lewis: “Quando vedi qualcosa che non è corretto, non giusto, hai il dovere morale, la missione e il mandato di alzarti in piedi e parlare, di metterti in mezzo, metterti nei guai, guai buoni (good trouble), guai necessari” (John Lewis, 2016). Stanley non è il primo a inserire un sottotesto politico in questa giornata, già lo aveva fatto Jana Al Obeydine di A Dance Mag e lo avevano suggerito Birch e Ahmed durante la breve tavola rotonda sulle cover: che si parli di Stati Uniti o di UK ed Europa, gli speaker sembrano uniti nel voler sottolineare il loro disappunto e la loro delusione, molto spesso la loro paura, nei confronti del clima politico attuale a livello globale.
Prende poi la parola Valerie Wickes di Beauty Papers, la rivista che cerca di raccontare la bellezza al di là degli stereotipi e dei brand. Il suo intervento è davvero brevissimo, ma riesce a pronunciare forse una delle frasi più interessanti dell’intera giornata: “magazines used to be influencers, but they became brand messengers”, cioè “le riviste erano i veri influencer, ma sono diventate semplici ambasciatori dei brand” (potremmo liberamente tradurre “dei marchettari”). Nulla di più vero.
Uno spiraglio all’interno dell’editoria mainstream ci è aperto da Tom Meredith, direttore creativo di ELLE UK. Il suo è un viaggio interessante che dall’edizione inglese l’ha portato a quella francese e poi di nuovo a quella britannica come Creative Director a partire dal 2017. Parlare in pubblico non è il suo forte, ma mostra come il suo approccio alle copertine (e ai redazionali di moda) sia figlio sia della storia della rivista (mostra vari esempi storici dell’edizione francese) che del nostro tempo (“gli strilli in copertina non sono necessari a vendere una rivista”): ed ecco che sotto la sua direzione le modelle in copertina guardano negli occhi il lettore, stabilendo un contatto diretto forte e personale, e guadagnando una carica e una forza maggiore. All’insegna di alcune parole chiave – giocoso, grafico, positivo, intimo, divertente, individuale – anche il trattamento delle immagini all’interno della rivista, specialmente quando si tratta di immagini esistenti e non realizzate ad hoc, si fa nuovo e personale: ecco che le foto delle passerelle diventano un collage che diventa un gradiente di colori, così come le foto di location esotiche nella sezione sul viaggio: “in questo modo sai che stai guardando le pagine di Elle, non quelle di un qualunque altro mensile che ha una sezione travel”, spiega.
Anche a livello tipografico il lavoro fatto – in particolare sui redazionali – è innovativo ed elegante: il carattere creato ad hoc si chiama “Playful” e con esso realizzano giochi di posizionamento dei testi che costringono il lettore a muoversi e muovere la rivista per leggere, creando così aperture di impatto e respiro.
Segue Deidre Dyer, executive editor di No Man’s Land. Lo si può definire un brand magazine, in quanto dietro a questo progetto c’è The Wing, un coworking per donne che dal 2016 ad oggi ha aperto in varie località negli Stati Uniti (Flatiron e Soho a New York, Dumbo a Brooklyn, Washington DC, San Francisco) e l’anno prossimo aprirà anche a Londra. Un vero e proprio club privato che fornisce un luogo per lavorare alle iscritte, ma che si è rivelato un luogo di “sorellanza” dove anche femminismo e politica si tengono per mano. Le condizioni in cui si è trovata a lavorare Deidre, dal punto di vista del design, sono tra le più ideali: racconta di come abbiano collaborato con Pentagram, con oltre sei settimane passate solo sulla copertina, con oltre 60 opzioni grafiche diverse tra cui scegliere…
Tocca poi a Max Siedentopf di Ordinary. Dopo un excursus sulla sua vita, personale e professionale (dalla nascita in Namibia al trasferimento ad Amsterdam), arriva a raccontare i suoi progetti editoriali ed Ordinary nello specifico. Come suggerisce il nome, la rivisita si ispira ad un oggetto di uso comune – le posate di plastica, la spugna, il calzino bianco, la cannuccia – che viene allegato al numero stesso in un sacchetto trasparente applicato sulla copertina. All’interno, l’oggetto viene interpretato fotograficamente da vari fotografi, a cui viene data libertà di interpretazione.
A concludere la giornata è l’attesissimo intervento di Emmet Smith, Creative Director di National Geographic. Rinnovato graficamente lo scorso aprile grazie alla collaborazione con l’ex-Wired Scott Dadich (e la sua nuova avventura Godfrey Dadich), National Geographic ha dovuto fronteggiare una “reinvention” non da poco e Smith ce la racconta, portando l’attenzione sui contenuti.
La rivista è stata fondata sull’idea di “esplorazione”, ma cosa significa questo concetto nel 2018? La missione di National Geographic è quella di rivolgersi alle persone insaziabilmente curiose e di essere per loro fonte di ispirazione che stimola l’esplorazione, accresce la conoscenza e crea in loro nuove domande. Per fare ciò è stata rivista la presenza fotografica, la gabbia (ispirata dalla griglia del planisfero), la tipografia (con la realizzazione di due caratteri ad hoc, Marden ed Earle, a cura di Tal Leming di Type Supply), il logo (che appare in questa forma solo sulla copertina del magazine) e l’organizzazione e presentazione di sezioni e rubriche. National Geographic ha la non facile missione di rimanere un punto di riferimento nel panorama editoriale internazionale (con una tiratura di milioni di copie) e il racconto di Emmet Smith – dalla bellezza delle slide alla chiara attenzione e dedizione al valore del contenuto – prova che sono perfettamente in grado di accettare la sfida e di portarla avanti negli anni, con il coraggio di affrontare anche contenuti controversi ma quanto mai necessari (cita ad esempio il discusso numero “Revolution Gender” che recava in copertina la foto di una ragazzina transgender).
Come sempre, si fa l’ora di andare. La frase che mi porto via da questa edizione è “make good trouble”, ma soprattutto “make good magazines”.